Maremma Libertaria n 7
Sommario: R/Esistenza ! – Ancora su Piazza Fontana, Pinelli e Calabresi – l’Internazionale situazionista – Renzo Novatore- Marco Di Noi- Poeti maremmani- Cinema – Libri resistenti
R/Esistenza !
Un po’ per scherzo, un po’ per amore siamo arrivati al primo compleanno di Maremma Libertaria, all’inizio due cartelle scritte agli amici, strada e complici facendo, qualcosa di più. E, guarda caso festeggiamo il tutto il 25 aprile, alla Corte dei miracoli all’ex O.P. di Siena , con una serata a ingresso libero con concerti, mostre fotografiche, installazioni, documenti storici del nostro archivio, libri , vino rosso e cacio per tutti.


Corte dei miracoli, 25 aprile
Video : Partigiani, ci chiamavano ribelli http://youtu.be/UGiFA_EsQu4
Ancora su Piazza Fontana, Pinelli, Calabresi…..e sulla strage di Brescia

Il romanzo di una strage è, in prima battuta, un titolo ammiccante. Pasolini, Il romanzo delle stragi, io so ma non ho le prove: avete presente? Quella roba lì. Quella roba che nel film non c’è. Detto fuori dai denti: cominciano a svenderli a 3×2, i pasoliniani de noantri che si riempiono la bocca col coraggio della verità, il dovere della verità, la religione della verità fino all’estremo, e poi continuano a ruzzolare e razzolare come e peggio di prima. Il modo peggiore di uccidere una seconda o terza volta Pasolini è quello di usarlo come specchietto per le allodole: e Giordana, dopo aver girato un film su Pasolini nel quale, com’era suo dovere di intellettuale, lasciava intendere altri scenari e altri finali al di là di quelli giudiziari ufficiali, tradisce se stesso, il suo mentore e il pubblico con un film nel quale non si arriva neanche alle verità giudiziarie, figurarsi spingere lo sguardo un filo più in là.
Il romanzo di una strage è, quindi, un titolo menzognero. Perché “romanzo” dovrebbe alludere a un’opera di fantasia che non replica il reale, ma lo arricchisce attraverso una grammatica delle immagini che sopravanza quella grammatica delle parole che ripete il mondo. E in tal modo rende possibile dire ciò che la parola non può dire: la potenza della fantasia, si direbbe nella lingua di Dante. Ricorda Goffredo Fofi che il cinema italiano fu capace, all’indomani di dittatura e guerra, di opere che raccontarono ciò che ancora non si aveva la forza di dire. A l’alta fantasia qui mancò possa, si potrebbe dire: ma ciò ch’è certo è che qui s’è parsa la sua (di Giordana) nobilitade.
 Il romanzo di una strage è, dunque, un film pavido. Che non ha il coraggio di dire che non segmenti marginali o laterali dello Stato, ma lo Stato in quanto tale, o se si preferisce l’altra faccia dello Stato, il doppio Stato, pianificò e attuò coscientemente la strategia della tensione, delle stragi, dei depistaggi, al fine di “destabilizzare per stabilizzare”. A mettere la bomba (la “seconda”, quella “vera”) sono stati figuri di secondo o terzo piano, esaltati e manovrati da soggetti stranieri, o al massimo dei “servizi” – espressione buona per indicare tutti e nessuno. Non c’entra la Democrazia Cristiana, non c’entrano i padroni (neanche quelli che, tra una sambuca e un motorino, finanziavano lo stragismo), non c’entrano Guida e Allegra, non c’entra neanche Junio Valerio Borghese, e alla fine probabilmente nemmeno Umberto D’Amato. Al massimo i colonnelli greci, che tanto non ci sono più. Tutto qui, quel che c’è da sapere? Ne sapevamo di più non dico dalle contro-inchieste – a partire da La strage di Stato [qui] –, ma dal memoriale di Moro. Non c’era bisogno di Cattleya, di un cast sontuoso (e in buona parte meritorio), del pacchetto Giordana-Petraglia-Rulli. O forse sì, c’era proprio bisogno di loro. Perché, lo spiego tra breve
Il romanzo di una strage è, dunque, un film pavido. Che non ha il coraggio di dire che non segmenti marginali o laterali dello Stato, ma lo Stato in quanto tale, o se si preferisce l’altra faccia dello Stato, il doppio Stato, pianificò e attuò coscientemente la strategia della tensione, delle stragi, dei depistaggi, al fine di “destabilizzare per stabilizzare”. A mettere la bomba (la “seconda”, quella “vera”) sono stati figuri di secondo o terzo piano, esaltati e manovrati da soggetti stranieri, o al massimo dei “servizi” – espressione buona per indicare tutti e nessuno. Non c’entra la Democrazia Cristiana, non c’entrano i padroni (neanche quelli che, tra una sambuca e un motorino, finanziavano lo stragismo), non c’entrano Guida e Allegra, non c’entra neanche Junio Valerio Borghese, e alla fine probabilmente nemmeno Umberto D’Amato. Al massimo i colonnelli greci, che tanto non ci sono più. Tutto qui, quel che c’è da sapere? Ne sapevamo di più non dico dalle contro-inchieste – a partire da La strage di Stato [qui] –, ma dal memoriale di Moro. Non c’era bisogno di Cattleya, di un cast sontuoso (e in buona parte meritorio), del pacchetto Giordana-Petraglia-Rulli. O forse sì, c’era proprio bisogno di loro. Perché, lo spiego tra breveIl romanzo di una strage è un film vigliacco: ma appena un filino. Giusto un pelo, un pelino di vigliaccheria: ma pelo di cinghiale, spesso e duro. Forte coi deboli, indulgente coi potenti: piuttosto li si fa passare per coglioni (Rumor), sant’uomini cascati dal pero (Moro), iracondi poco ragionevoli (Saragat), stronzi (Guida e Allegra), ma colpevoli e complici mai. Valpreda (come in generale gli anarchici tutti, e anche Feltrinelli) è raffigurato come un esaltato, uno che ha tanti di quei lati oscuri da aver potuto davvero metterla, la bomba (quella “finta”). E per rafforzare questo quadro – tanto Pietro non può più difendersi, e di parenti che si battono per la sua memoria non ne sono rimasti, e anche se fossero nessuno dirige un giornale – il Valpreda del film, come il mostro della “macchina del terrore” che vollero fosse – fa su e giù da Milano a Roma, da Roma a Milano, poi di nuovo a Roma con la vecchia 500… Poco importa che in questi 40 anni Carla Fracci abbia confermato che Valpreda era a Roma per un provino alla RAI, dove si incontrarono e si salutarono (e le pressioni da lei ricevute per tacerlo); poco importa che Valpreda nei giorni dopo la strage era a letto col febbrone: «l’accusa voleva un Valpreda completamente fuori di senno che porta la bomba (in taxi), si costruisce un alibi milanese (a casa sua), si precipita a Roma (mostrandosi in pubblico), infine ritorna a Milano (per dare nuova conferma all’alibi milanese) e, veramente diabolico, si presenta al giudice Amati». Sono parole, queste, di Marco Nozza, Il pistarolo, Saggiatore, 2011, p. 45: libro che Giordana dichiara di aver letto. E Nozza è anche presente nel film – uno dei pochi meriti di questa pellicola, è di rendere onore ai “pistaroli” – Nozza, Cederna, Stajano, Palumbo. Ma è un onore anch’esso un po’ vigliacco: ogni volta che c’è da dire qualcosa di scomodo – l’agente Annaruma non è stato assassinato dai manifestanti, Pinelli aveva ambedue le scarpe ai piedi, cose così – è sempre la voce di un giornalista che lo dice:
 mai una telecamera che inquadra, mai il film che mostra, figurarsi se Giordana ha il coraggio di dirvi cos’è davvero successo al Pinelli, quella sera che a Milano era caldo. Dietro al dito dei pistaroli gli autori del film si nascondono, metti mai che arrivi una querela… Basterebbe mostrare la foto del cosiddetto “riconoscimento” di Valpreda, lui scarmigliato e insonne in mezzo a quattro agenti vestiti da manichini Facis: ma così è troppo facile, si corre il rischio di dire la verità. E Valitutti, il testimone che NON VIDE uscire Calabresi dalla stanza della defenestrazione [qui la sua testimonianza]? Cucchiarelli, nel suo Il segreto di piazza Fontana, fa fare a Pinelli, Calabresi e compagnia il giro dei quattro cantoni della Questura, neanche fossero le stanze di Hogwarts, per trovare un angolo nascosto alla visuale di Valitutti: Giordana lo trasforma in un mezzo scemo che vede Calabresi uscire, poi tace, poi mente. Sapete, gli anarchici…
mai una telecamera che inquadra, mai il film che mostra, figurarsi se Giordana ha il coraggio di dirvi cos’è davvero successo al Pinelli, quella sera che a Milano era caldo. Dietro al dito dei pistaroli gli autori del film si nascondono, metti mai che arrivi una querela… Basterebbe mostrare la foto del cosiddetto “riconoscimento” di Valpreda, lui scarmigliato e insonne in mezzo a quattro agenti vestiti da manichini Facis: ma così è troppo facile, si corre il rischio di dire la verità. E Valitutti, il testimone che NON VIDE uscire Calabresi dalla stanza della defenestrazione [qui la sua testimonianza]? Cucchiarelli, nel suo Il segreto di piazza Fontana, fa fare a Pinelli, Calabresi e compagnia il giro dei quattro cantoni della Questura, neanche fossero le stanze di Hogwarts, per trovare un angolo nascosto alla visuale di Valitutti: Giordana lo trasforma in un mezzo scemo che vede Calabresi uscire, poi tace, poi mente. Sapete, gli anarchici…E Pinelli? Uno schizzetto di fango, ma piccolo, appena appena: il sospetto che le bombe sui treni, l’8 agosto 1969, le abbia messe lui. È vero, verissimo, che alla fine apprendiamo che quelle bombe le misero i fascisti: ma la modalità del prefetto ex machina che verbosamente rivela tutto ha un impatto retorico ben diverso da un sospetto che è stato più volte reiterato nell’azione filmica. Ma forse Giordana, Rulli e Petraglia queste cose da cinematografari non le sanno, faranno un altro mestiere. Resta che Pinelli viene assolto dallo spettatore non perché la trama lo dimostri: perché a rappresentarcelo come un uomo buono ci mette la sua faccia Favino. La responsabilità di mostrare il vero Pino Pinelli, Giordana non se l’è presa: c’era il rischio di far fare una brutta figura al commissario Calabresi. Per la cronaca: Pinelli quelle bombe non poteva averle messe, perché era su un treno partito da dieci minuti quando il treno su cui furono messe arrivò in stazione a Milano. È scritto negli atti (Sofri lo riporta a p. 89 del suo 43 anni), bastava leggerli: Giordana e gli sceneggiatori dicono di averlo fatto, sarà…
 Il romanzo di una strage è un film politicamente corretto, che conclude una trilogia iniziato con Maledetti vi amerò e La caduta degli angeli ribelli. Nel mezzo, Rulli e Petraglia ci hanno infilato anche la sceneggiatura di La prima linea. Cos’hanno in comune questi docu-film? Il racconto di un decennio depurato del contesto sociale, delle lotte, delle ragioni del conflitto di classe. A parte qualche corteo e qualche manganellata, del conflitto di classe stesso. Lo spettatore ideale presupposto da Giordana è quell’archetipico cretino che ritorna in Italia in Maledetti vi amerò, ed è riuscito, dal Venezuela (ma dov’era? In cima a una montagna?) a non sapere nulla di quel che era accaduto in Italia: per sapere dell’assassinio di Aldo Moro ha bisogno di un commissario di polizia che gli fa leggere il numero di “Lotta Continua”. Gli spettatori a cui Giordana si rivolge sono così: non sanno nulla, e si fidano ciecamente del nulla che Giordana & C. hanno da dire loro. E quello che Giordana ha da raccontare loro è una storia rassicurante, nella quale i conflitti sociali sono opera di qualche svitato (“Svitol” è per l’appunto il nome del protagonista del suo primo film), di cui forse non sappiamo molto, ma tant’è… «Com’è possibile che ci si possa accontentare di parodie di ricostruzione storica come questa, da opera dei pupi, da filodrammatica e da sceneggiata, da museo delle cere, da gara paesana di imitatori, tra santini e macchiette e tra opposti buoni e i morti non possono più parlare, i vivi che sanno tacciono, i “servizi” – nazionali e internazionali – continuano, come hanno sempre fatto, a insabbiare, a inquinare, a manovrare, i politici a preferire la retorica alla persuasione», si chiede Goffredo Fofi: perché è rassicurante sapere che qualcun altro pensa e provvede per noi – sia pure un Aldo Moro santo subito fin dalla prima inquadratura, impersonato da un insopportabile Fabrizio Gifuni con il suo perenne essere-sopra-le-righe, e al quale bisognerebbe dire che non solo non è Gian Maria Volonté, ma neanche Roberto Herlitzka. Più inquietante sarebbe scoprire che il conflitto aveva delle cause, che c’è stato davvero, che ha lasciato delle tracce, degli sconfitti e dei vincitori. Ma questo sarebbe cinema, di quello vero.
Il romanzo di una strage è un film politicamente corretto, che conclude una trilogia iniziato con Maledetti vi amerò e La caduta degli angeli ribelli. Nel mezzo, Rulli e Petraglia ci hanno infilato anche la sceneggiatura di La prima linea. Cos’hanno in comune questi docu-film? Il racconto di un decennio depurato del contesto sociale, delle lotte, delle ragioni del conflitto di classe. A parte qualche corteo e qualche manganellata, del conflitto di classe stesso. Lo spettatore ideale presupposto da Giordana è quell’archetipico cretino che ritorna in Italia in Maledetti vi amerò, ed è riuscito, dal Venezuela (ma dov’era? In cima a una montagna?) a non sapere nulla di quel che era accaduto in Italia: per sapere dell’assassinio di Aldo Moro ha bisogno di un commissario di polizia che gli fa leggere il numero di “Lotta Continua”. Gli spettatori a cui Giordana si rivolge sono così: non sanno nulla, e si fidano ciecamente del nulla che Giordana & C. hanno da dire loro. E quello che Giordana ha da raccontare loro è una storia rassicurante, nella quale i conflitti sociali sono opera di qualche svitato (“Svitol” è per l’appunto il nome del protagonista del suo primo film), di cui forse non sappiamo molto, ma tant’è… «Com’è possibile che ci si possa accontentare di parodie di ricostruzione storica come questa, da opera dei pupi, da filodrammatica e da sceneggiata, da museo delle cere, da gara paesana di imitatori, tra santini e macchiette e tra opposti buoni e i morti non possono più parlare, i vivi che sanno tacciono, i “servizi” – nazionali e internazionali – continuano, come hanno sempre fatto, a insabbiare, a inquinare, a manovrare, i politici a preferire la retorica alla persuasione», si chiede Goffredo Fofi: perché è rassicurante sapere che qualcun altro pensa e provvede per noi – sia pure un Aldo Moro santo subito fin dalla prima inquadratura, impersonato da un insopportabile Fabrizio Gifuni con il suo perenne essere-sopra-le-righe, e al quale bisognerebbe dire che non solo non è Gian Maria Volonté, ma neanche Roberto Herlitzka. Più inquietante sarebbe scoprire che il conflitto aveva delle cause, che c’è stato davvero, che ha lasciato delle tracce, degli sconfitti e dei vincitori. Ma questo sarebbe cinema, di quello vero.Il romanzo di una strage è, infine, un film discretamente cialtrone. Lascia che siano le facce degli attori, e non la trama e la tecnica narrativa, a orientare il pubblico: provate a mettere al posto di Favino e Mastrandrea due facce qualunque, per dire. Che Moro e Calabresi siano da santificare, s’è detto, lo si capisce dalle prime inquadrature: il film comincia nel 1969, ma ciò che è accaduto ai due è retroattivamente già presente nella fisiognomica, e pazienza se Calabresi il vizio di interrogare gli anarchici sulla balaustra della finestra lo aveva anche prima. Per Valpreda no, non c’è retroazione: ha pagato e sofferto come pochi, ma la faccia che resta impressa è quella dell’esaltato del ’69. Stesso discorso per l’espressione da genio malvagio che accomuna Delle Chiaie e Freda: fisiognomica di basso livello davvero. E tra un’inquadratura piatta e una scelta scenica banale (dovrà pur passare in televisione, questa roba), senza mai un piano-sequenza degno di questo nome, un movimento di macchina originale, un’inquadratura particolare, arriviamo al gran finale, con la famosa finestra nella “famosa stanza” inquadrata in secondo piano, in leggera dissolvenza, mentre in primo piano D’Amato spiega a Calabresi che la terra gira attorno al sole, l’erba di una volta era più verde e i neri hanno il ritmo nel sangue. Da un regista come Giordana non si può pretendere che impari, riguardandosi chessò, Deserto rosso o Professione reporter, come Antonioni riusciva a fare di una finestra un’immagine alla Mark Rothko. «Com’è che artisti, intellettuali e professionisti delle comunicazioni di massa, dei settori più ufficiali di esse, non riescano mai o quasi mai a raccontare degnamente il tempo passato e a essere all’altezza dei problemi di questo, che dei primi ha ereditato il peggio?», si chiede ancora Fofi: beh, se non sono capaci dei fondamentali del mestiere, la risposta c’è. E la domanda diventa un’altra, che forse è poi la stessa: com’è che questa Italia osanna come intellettuali e artisti gente così?
A questo link si può scaricare liberamente il punto di vista di Adriano Sofri su Piazza Fontana, son molte pagine ma ne vale la pena
La verità sulle stragi sacrificata sull’altare del compromesso storico
Milani è convinto che la verità sarebbe potuta venire fuori subito se ci fosse stato nella seconda parte degli anni 70 un diverso atteggiamento politico più deciso nel denunciare le ambiguità istituzionali, «Credo che subimmo – aggiunge – una certa timidezza del Pci dell’epoca che non voleva rischiare di compromettere il rapporto con la Dc. Ma fino a quando la ragion di Stato avrà il sopravvento sulla ricerca della verità?».
La verità sulle stragi sacrificata sull’altare del compromesso storico. Il sospetto di Manlio Milani non è affatto infondato. Il Pci concepiva il ricorso allo strumento giudiziario come una leva per facilitare i suoi scopi politici, così le inchieste subivano accelerazioni o rallentamenti a seconda degli interessi del momento. Ciò spiega la linea della fermezza, il massimo di repressione con tanto di leggi speciali e torture contro la lotta armata per il comunismo, che si mise di traverso alla strategia del compromesso storico, ed al contrario i tentennamenti verso la Dc sulle stragi.
Ma se le cose stanno così e se tutte le inchieste, al di là degli esiti processuali, sono sempre giunte ad una identica ricostruzione del contesto ambientale nel quale ha avuto origine la strage di Brescia, come le altre: i settori del neofascismo del triveneto collegati, infiltrati, inquinati dalla presenza di agenti di varie intelligences Nato e dei nostri apparati, la vera domanda da porre non è forse un’altra: non è stata malrisposta la fiducia riversata verso la magistratura affinché potesse arrivare ad una verità certificata processualmente? Se di mezzo c’è lo Stato con i suoi apparati e le inconfessabili strategie elaborate in sede atlantica, è pensabile l’accertamento della verità da parte della magistratura senza che ciò non proceda insieme ad un mutamento politico radicale delle istituzioni coinvolte?
Non è stata una follia ritenere che la liturgia del processo penale potesse svolgere una funzione terapeutica, favorendo la riparazione psicologica delle vittime?
A nostro avviso si è trattato di una deriva sbagliata, anzi devastante poiché:
a) ha innescato una privatizzazione del diritto di punire;
b) la giustizia processuale ha perso in questo modo il suo ruolo peculiare di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di ricostruzione clinica della persona offesa;
c) conseguenza che favorisce il rischio di verità giudiziarie di comodo, verità politiche – altrimenti dette “ragion di Stato” – necessarie a placare domande che vengono dall’opinione pubblica o servono a lenire semplicemente la sofferenza dei familiari, ad appagarne il risentimento;
d) devasta la dimensione psicologica delle vittime stesse, messe di fronte all’assurdo paradosso di dover pretendere verità da quello stesso Stato coinvolto nei fatti incriminati;
e) verità che evidentemente non potrà mai venire senza che sia investita la dimenzione del cambiamento politico delle istituzioni coinvolte;
f) ne può uscire soltanto un atteggiamento vittimistico e querulante che di fronte al frustrante fallimento degli esiti processuali, o peggio al mancato appagamento che la scena giudiziaria offre (“la verità giudiziaria non dice tutto”, “i colpevoli nascondono altre verità”, ”la pena deve essere infinità anche una volta sconata per intero”), trascina la figura della vittima in una spirale di risentimento senza fine, di avvitamento rancoroso;
E’ sulla verità storica che occore dunque lavorare. Ciò dipende da quelle categorie, gli imprenditori della memoria, che lavorano con la materia storica ma dipende anche e soprattutto dall’autorganizzazione sociale, dalla capacità di creare le condizioni politiche perché questa verità esca fuori.(Insorgenze)

Marco insegnava all’Università di Siena tecniche del linguaggio cinematografico. La sua morte improvvisa e assolutamente prematura ci ha privato da tempo, un tempo che non si riconcilia nè si scioglie, di un fratello. In fondo a queste brevi righe riportiamo alcuni suoi lavori, convegni e progetti che continuano nel suo nome, e che vedono coinvolti colleghi, studenti, e tutti coloro, e sono tanti, con cui ha collaborato e si è speso senza sosta. Noi però vogliamo ricordare anche il “nostro” Marco, l’amico fraterno, autore di una dura gavetta e tanti lavori per mantenersi agli studi, il Marco che non aveva mai risparmiato l’impegno dalla parte degli oppressi, l’amore per il cinema, la generosità naturale che aveva per gli altri. Il compagno che ci assisteva nei nostri progetti e cortometraggi, che veniva ad imbiancare la nostra comune casa a Siena, che ci portava il vino della sua Manduria e l’incoraggiamento nei momenti difficili.
Marco, il tuo sorriso, il tuo affetto, la tua persona semplice e bella, ci mancano e ci mancheranno tantissimo. ( S.P.)
qui il link al Centro studi Marco Di Noi
http://associazionelevel5.com/
Apertura alla consultazione del Fondo Marco Dinoi
aprile 10, 2012
Il Fondo è collocato presso i locali della Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Siena. L’accesso e la consultazione del materiale è regolato dalle norme della Biblioteca.
Per maggiori informazioni clicca qui.
Hanno partecipato all’incontro Alessandro Cannamela, Christian Uva, Roberto Venuti e Luca Venzi.
L’evento, che rientra nella programmazione della rassegna LUNEDì LIBRI, ha proposto un momento di riflessione intorno alla raccolta di interventi del seminario “Lo sguardo e l’evento. Letture incrociate”, tenutosi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena tra gennaio e maggio 2009. Il ciclo di seminari era dedicato alle riflessioni che Marco Dinoi ha raccolto nelle pagine del suo ultimo lavoro: Lo sguardo e l’evento. I media, la memoria, il cinema, pubblicato postumo nel maggio 2008 per l’editore Le Lettere di Firenze.Al seguente link potete consultare la premessa del volume.
qui le tracce audio degli interventi di Marco al convegno ” lo spazio del reale nel cinema italiano contemporaneo”
http://associazionelevel5.com/il-fondo/tracce-audio/
qui invece il link di Al Kamandjati (il Violinista) con la regia video di Marco Di Noi
http://www.auditorium.com/eventi/4906493

Se La società dello spettacolo di Guy Debord è reputato il testo che meglio ha saputo esprimere in maniera compiuta la critica formulata dai situazionisti al mondo esistente, il movimento delle occupazioni del maggio ‘68 in Francia viene considerato l’apice della loro pratica, il loro ingresso nella Storia. Ad una storiografia accademica che ha intenzionalmente ignorato o minimizzato il ruolo svolto dall’IS nella genesi e nel successivo sviluppo di quella primavera di liberazione, preferendo puntare i suoi riflettori sul più presentabile “Movimento 22 marzo”, se n’è via via contrapposta una pro-situs che, invertendo la tendenza, si è prodigata per innalzare un monumento ai suoi beniamini.
Ma non è difficile accorgersi come la cattiva reputazione che i situazionisti si vantano di godere presso il pubblico ogni qualvolta vengono rievocate quelle giornate di maggio sia in gran parte costruita a tavolino, frutto di un banale sillogismo che a furia d’essere ripetuto si è consolidato in verità acquisita. Questi abili impresari di se stessi hanno potuto fare affidamento, oltre che sul loro indiscutibile talento, sull’ausilio dei loro concessionari interessati a cantare le lodi al marchio di fabbrica di cui si son fatti rappresentanti, nonché sull’involontario contributo dei mass-media, usi a distribuire ruoli fittizi fra i protagonisti di un evento al momento della sua ricostruzione mediatica. Dopo che al giovane studente Cohn-Bendit erano stati assegnati i panni di leader della protesta, mancava qualcuno un po’ più maturo che fosse credibile nella parte dell’anima nera della rivolta. L’IS era perfetta per recitare questo tenebroso ruolo e non chiedeva di meglio.
Se Bela Lugosi si era talmente identificato nel personaggio che lo aveva reso famoso al punto di farsi seppellire da morto con addosso il costume di Dracula, così i situazionisti non hanno più smesso di atteggiarsi a “cattivi maestri” anche quando la commedia era già finita da un pezzo e il pubblico aveva lasciato la sala. In ciò non si può dire che si siano distinti dagli altri “gruppuscoli” che all’epoca costituivano un abituale obiettivo delle loro contumelie, essendosi anch’essi affrettati a cavalcare la tigre della rivolta del maggio per trarre profitto della sua forza e bellezza ed aumentare la propria clientela. D’altronde l’entusiasmo sollevato in tutto il mondo da quei giorni di passione rappresentava un investimento troppo ghiotto per lasciarselo sfuggire. Ne nascerà una patetica competizione fra i situazionisti (secondo cui tutto era nato dall’agitazione iniziata nel gennaio 1968 a Nanterre da quattro o cinque “antistudenti”, gli Arrabbiati, influenzati dall’IS stessa), alcuni anarchici (che non tralasceranno mai di ricordare il clamore suscitato dalla lite avvenuta l’8 gennaio fra il ministro Missoffe e Cohn-Bendit e i provvedimenti poi decisi contro quest’ultimo) e i trotskisti (persuasi che nulla sarebbe accaduto senza il fervore attivista dei militanti della loro organizzazione giovanile, la Gioventù Comunista Rivoluzionaria). Una volta assaporate le luci della ribalta, le primedonne del maggio ‘68 metteranno in atto ogni trucco pur di ricevere l’applauso più fragoroso, nella consapevolezza che «per questo modo montò tanto sua nomea che catuno si facea suo accomandato».
Ma qual è il sillogismo che ha aiutato i situazionisti nella loro scalata alla gloria imperitura? Gli avvenimenti del maggio ‘68 in Francia — uno sciopero selvaggio esteso a tutta la società, la critica generalizzata dei ruoli e dell’alienazione, la scomparsa dello Stato per diversi giorni — costituiscono il più grande tentativo rivoluzionario mai avvenuto in un paese industriale avanzato. L’Internazionale Situazionista ha legato indissolubilmente il suo nome a quegli eventi. Quindi, l’IS è l’organizzazione rivoluzionaria più radicale che abbia mai operato in una democrazia moderna occidentale — la Storia ne è testimone.
Il ragionamento non lascia margini di dubbio. Peccato che come in tutti i sillogismi a furia di cercare conferme si finisca col forzare la realtà. Questo genere di concatenazioni logiche tornano utili a maggior ragione quando la loro impeccabilità si rivela solo apparente.
Tralasciamo le acrobazie della logica e prendiamo in considerazione i fatti. Sebbene fin da allora un numero imprecisato di storici abbia cercato di addomesticare il maggio francese spacciandolo come il prototipo della “protesta studentesca”, si è trattato effettivamente del «più grande momento rivoluzionario che la Francia abbia conosciuto dopo la Comune di Parigi» (IS n. 12). Nulla da dire anche sul fatto che gli aderenti all’IS vi abbiano partecipato attivamente, contribuendo a soffiare sul fuoco. Ma, fatte queste premesse, sarebbe delirante concludere che la rivolta scoppiata in quella lontana primavera sia avvenuta per merito dei situazionisti, o che questi ne siano stati i trascinatori.

Anche prendendo per buona la versione situazionista dei fatti — cioè attribuire a quattro o cinque Arrabbiati la responsabilità dei disordini scoppiati a Nanterre, considerati il punto di partenza della rivolta — sarebbe come affermare che la rivoluzione del 1918 in Germania sia stata opera dei marinai che reclamavano miglior cibo, o che la rivolta di Los Angeles del 1992 sia stata provocata da Rodney King e dal suo pestaggio da parte della polizia. Gli esempi che si potrebbero fare seguendo questa logica tortuosa sono infiniti, ma ciò non toglie che in questa maniera non si fa altro, per mere ragioni di bottega, che confondere il pretesto da cui è scaturito un evento storico con la causa che l’ha prodotto. È innegabile l’apporto fornito dai situazionisti nel maggio ‘68 all’esplosione della rivolta, ma è altrettanto evidente che il loro contributo è stato artificiosamente ingigantito e trasformato in mito incantatorio, operazione proseguita da molti dei loro seguaci. Se ci si prendesse la briga di dare uno sguardo all’attività dei situazionisti più da vicino — dopo aver spento gli accecanti riflettori della leggenda — e se si facesse risalire la loro azione al contesto sociale dell’epoca, diventerebbe facile ridimensionare la parte da loro svolta nei fatti che li avrebbero resi celebri.
In questo senso nulla è più istruttivo della lettura comparata delle ricostruzioni realizzate dagli stessi situazionisti o dai loro simpatizzanti. Ci riferiamo al libro di René Viénet Arrabbiati e situazionisti nel movimento delle occupazioni, all’ultimo numero della rivista dell’IS, all’opera di Mario Lippolis Ben venga maggio e ’l gonfalon selvaggio! e alla storia dell’IS scritta da Jean-François Martos Rovesciare il mondo. I quesiti attorno ai quali ruotano le interpretazioni in chiave pro-situazionista di quei “cattivi giorni” sono fondamentalmente due. Cosa differenziava la rivolta francese dagli avvenimenti che in quello stesso periodo travagliavano il resto dell’Europa ed anche gli Stati Uniti: qual è cioè l’elemento che l’ha resa più radicale rispetto alle altre contestazioni dell’epoca? E a chi attribuire il merito di aver dato inizio alla rivolta, di averla meglio incarnata?
La risposta alla prima domanda è facile: solo in Francia il movimento non rimase circoscritto all’ambito universitario, ma si estese in modo significativo al resto della società. La svolta avvenne il 14 maggio, quando, secondo Viénet, «gli operai della Sud-Aviation di Nantes occuparono la fabbrica e vi si barricarono, dopo aver rinchiuso il direttore Duvochel e alcuni funzionari negli uffici, sbarrandone le porte». Questa occupazione «fu dappertutto considerata come un fatto di fondamentale importanza». Il giorno seguente, il 15, alla notizia di quanto avvenuto a Nantes «gli operai della Renault di Cléon (Seine-Maritime) entravano in sciopero e decidevano di occupare la fabbrica, sequestrandone anch’essi i dirigenti. Pure le fabbriche di Lockheed a Beauvais e Unulec a Orléans sospesero il lavoro. Sul finir della sera, a Parigi, all’ora di uscita degli spettatori, due o trecento persone si recarono all’Odéon-Théatre de France e vi si insediarono come occupanti».

E non è finita. «Il mattino del 16 maggio, alla notizia dell’occupazione della Renault-Cléon, una parte dei lavoratori delle Nuove Messaggerie della Stampa Parigina cominciò a sua volta uno sciopero selvaggio». È quello stesso giorno, il 16 maggio, a segnare «il momento in cui la classe operaia, in modo irreversibile, comincia a dichiararsi favorevole allo sviluppo del movimento. Alle 14 la fabbrica Renault di Flinis è già occupata. Tra le 15 e le 17 lo sciopero selvaggio dilaga alla Renault-Billancourt. Le occupazioni di fabbriche cominciano a diffondersi in tutta la provincia».
Ed è in questo contesto di euforia, quando il movimento delle occupazioni aveva già cominciato ad estendersi ai posti di lavoro, che il Comitato di occupazione della Sorbona, sostenuto dai situazionisti, diramerà alle 15.30 del 16 maggio il famoso comunicato che esortava «all’occupazione immediata di tutte le fabbriche in Francia e alla formazione di Consigli Operai». Questa è la ricostruzione fatta a caldo da Viénet nel luglio di quello stesso anno, quando il ricordo di quegli eventi era ancora fresco nella memoria di chi li aveva vissuti.
Passiamo ora alla versione dei medesimi fatti presentata nel 1989 da Martos in un libro pubblicato in Francia non da una casa editrice commerciale, ma dalle edizioni Lebovici che in qualche misura sono state per lunghi anni le edizioni “portavoce” di ciò che restava dell’IS. Ebbene, così Martos ricostruisce quei giorni: «14 maggio: a Nantes, gli operai della Sud-Aviation occupano la fabbrica e vi si barricano. Dal canto loro i situazionisti si fondono con l’élite degli estremisti di Nanterre e formano il Comitato Arrabbiati-Internazionale Situazionista che già l’indomani controllerà il Comitato di occupazione della Sorbona. – 16 maggio, ore 15: il Comitato Arrabbiati-Internazionale situazionista, in nome della Sorbona occupata, chiama “all’occupazione immediata di tutte le fabbriche in Francia e alla formazione di Consigli operai”… Lo stesso giorno, alla Renault-Billancourt, la base impone lo sciopero. Lo sciopero selvaggio si estende poi all’insieme del paese e mobilita undici milioni di lavoratori».
Ecco come si costruisce una leggenda. Nella sua cronologia Martos tralascia la data del 15, giorno in cui l’occupazione si estese a tre fabbriche ed un teatro, così come dimentica di dire che il 16 maggio, prima che il comunicato della Sorbona fosse reso pubblico, erano già state occupate le Nuove Messaggerie e una fabbrica Renault. Quanto alla fabbrica più grande di Francia, la Renault-Billancourt, è ridicolo il tentativo di Martos di far passare la sua occupazione come una conseguenza diretta di quel comunicato diffuso dalla Sorbona.
È invece evidente, come sostiene anche Lippolis, che l’agitazione in quella fabbrica si sia manifestata «tra le 14 e le 17.30, sotto l’effetto delle notizie di Nantes, Cléon, Flinis». In poche parole, i situazionisti incitarono all’occupazione delle fabbriche solo dopo che questa era già cominciata ed era ormai un dato acquisito.
Ma allora, quando e dove avviene lo storico incontro fra studenti e operai? Non a Parigi, né a Nanterre — sedi dell’attività situazionista — bensì in provincia, a Nantes e a Lione. È lì che il movimento delle occupazioni si manifesta compiutamente per la prima volta. L’occupazione della Sud-Aviation a Nantes avvenne dopo che il giorno precedente, lunedì 13, studenti ed operai si erano battuti assieme contro la polizia. Il giorno seguente, alcuni lavoratori fecero tesoro dell’esperienza e occuparono la fabbrica, ricevendo subito l’attiva solidarietà degli studenti. Pare che successivamente Nantes sia stata l’unica città della Francia dove gli scioperanti, invece di limitarsi ad occupare il proprio posto di lavoro, hanno cercato di dare vita a una nuova forma di organizzazione sociale. Nel suo libro Lippolis sostiene addirittura che non è stata affatto la Sud-Aviation di Nantes la prima fabbrica francese ad essere occupata, martedì 14 maggio, poiché già il giorno precedente «a Lione gruppi di operai e di studenti, dopo una lunga agitazione comune, invadono insieme la Rhodiaceta e proclamano autonomamente la prosecuzione dell’astensione dal lavoro». Nella stessa città, aggiunge Lippolis, studenti e operai si erano scontrati con la polizia già il 9 maggio, attaccando le sedi di due giornali. E quando i situazionisti affermano di aver «approvato la condotta di alcuni gruppi rivoluzionari che abbiamo potuto conoscere, a Nantes e a Lione», non fanno che sottolineare la loro estraneità all’azione svolta dagli insorti in quelle province.
Pur consapevoli di essere stati solo una goccia in mezzo all’oceano in burrasca, i situazionisti non rinunceranno comunque a rivendicare la paternità di quell’ondata che, per un istante, ha minacciato di travolgere il vecchio mondo. Per riuscirci presenteranno i fatti che hanno preceduto il maggio seguendo la solita logica riduzionista di stampo pubblicitario, prendendo come punto di riferimento il proprio microcosmo. Dunque, essendo l’occupazione delle fabbriche provocata dall’occupazione delle università, essendo l’occupazione delle università nata dall’agitazione diffusasi fra gli studenti, essendo l’agitazione fra gli studenti iniziata col celebre scandalo di Strasburgo nel 1966, ed essendo impossibile parlare dello scandalo di Strasburgo senza il contributo dell’IS, ne consegue che il maggio francese debba tutto all’IS.

Ebbene, il 1966 era stato l’anno dello scandalo di Strasburgo, in seguito alla pubblicazione del famoso Della miseria nell’ambiente studentesco, edito a spese della locale sezione dell’Unione Nazionale degli Studenti di Francia. Nel ripercorrere i fatti accaduti, vantandosi del ruolo svolto, i situazionisti annunciarono che tutte le rivolte a venire, ovunque fossero apparse, avrebbero costituito solo una conferma delle loro tesi. Va da sé che gli studenti che in quel periodo erano scesi in piazza in tutto il mondo non erano stati affatto fulminati sulla via della rivoluzione dal Verbo dell’IS, ma questo dubbio non turbò mai la mente dei situazionisti i quali erano invece persuasi che «le nostre idee sono in tutte le teste — è ben noto —».
Eppure fu lo stesso Viénet a sostenere che «il nuovo sviluppo rivoluzionario nei paesi industrializzati… può essere datato dall’insurrezione operaia del 1953 a Berlino Est», cui seguì «la rivoluzione ungherese dell’ottobre 1956». Senza contare che «alla fine del 1964 lo scatenamento dell’agitazione degli studenti di Berkeley stava mettendo in discussione l’organizzazione della vita nel più sviluppato paese capitalistico», dando il via ad un movimento che si sarebbe esteso anche in Europa, soprattutto in Germania, in Italia e in Francia. E ci sia permesso di dubitare che gli studenti di Berkeley fossero influenzati dall’IS allorché iniziarono le loro proteste, dopo che l’amministrazione universitaria aveva negato l’uso di una ristretta zona pubblica dove i vari gruppi studenteschi politicizzati erano soliti svolgere attività di volantinaggio e propaganda. Gli studenti di Strasburgo non avrebbero mai preso contatti con l’IS se non fossero stati eccitati da quanto avveniva altrove all’interno delle università. A loro volta gli Arrabbiati di Nanterre avevano già iniziato le loro azioni di disturbo prima del loro incontro con i situazionisti, avvenuto secondo Viénet dopo il 21 febbraio. Va anche ricordato che gli Arrabbiati non presero affatto il proprio nome dalla corrente più estremista espressa dalla Rivoluzione francese del 1789. Enragés era in realtà la definizione con cui la stampa sensazionalistica dell’epoca bollava tutti gli studenti che partecipavano alle manifestazioni di protesta a Nanterre. E fu sempre Viénet a precisare come in rue Gay-Lussac, la notte di quel famoso venerdì 10 maggio, fra gli insorti che per più di tre ore si scontrarono con la polizia fossero presenti studenti, liceali, blouson-noir, operai, stranieri, ragazze, nonché «elementi rivoluzionari di quasi tutti i gruppi estremisti».
Che dire poi dell’involontario contributo dato dalle autorità universitarie e dalla brutalità poliziesca nel far precipitare la situazione?
Insomma, di fronte all’immane opera collettiva che è sempre stato ogni tentativo rivoluzionario — momento di rottura generato dall’intreccio di innumerevoli elementi, fattori e circostanze — cercare di stabilire a chi spetti il merito di averlo scatenato è un’operazione del tutto vana, che può rivestire qualche interesse solo agli occhi di politicanti in cerca di reclute, di procacciatori di medaglie, di fabbricanti di santini.
Nel suo libro Martos si premura di riportare che «quando nel 1975 la ricerca universitaria si dedicò al linguaggio scritto del maggio 1968, approdò grazie ad un uso pertinente dei computer ad alcune verità — che una corte di specialisti informati tentano ancora di tener nascoste. Des Tracts en mai 68 (Volantini nel maggio ‘68) riesce così a definire qualitativamente la produzione scritta di tutti i gruppi che agivano all’epoca, a partire da precisi criteri quantitativi che permettono di misurarne il vocabolario e il contenuto. Assistito da computer, questo avanzato metodo comparato ottenne risultati incontestabili: per la diversificazione ad oltranza delle forme lessicali, per l’estensione e la ricchezza del vocabolario, l’Internazionale situazionista usò nel maggio 1968 un linguaggio più originale di tutti gli altri».
E va bene. Ci inchiniamo davanti ai «risultati incontestabili» ottenuti mediante «un uso pertinente dei computer». Ma, una volta assegnato ai situazionisti il premio letterario “Maggio ‘68”, bisognerebbe esaminare anche il contenuto oltre allo stile con cui espressero le loro idee. Chi si fosse preso la briga di scorrere la montagna di volantini prodotti in quei giorni dal movimento nel suo insieme avrà notato come, al di là dello stile letterario, gli interventi situazionisti non si siano affatto contraddistinti da quelli di molti altri gruppi allora attivi. Basterebbe leggere i testi diffusi dal Comitato d’Azione Lavoratori-Studenti Censier che, se da un lato era ancora legato alla vecchia retorica operaista, dall’altro ha dimostrato di avere una capacità di collegamento e coordinamento all’interno delle fabbriche occupate — cioè laddove anche per l’IS si stava svolgendo la partita decisiva — indiscutibilmente superiore a quella del Comitato per il Mantenimento Delle Occupazioni. Fra i rivoluzionari più radicali, tutti indicarono nell’abolizione della società di classe lo scopo ultimo del movimento, tutti denunciarono il ruolo apertamente controrivoluzionario degli stalinisti e dei sindacalisti, tutti si resero conto verso la fine di maggio dell’impasse in cui si stava arenando il movimento e ne mostrarono alcune possibili prospettive. E tutti si accontentarono più che altro di denunciare la gravità della situazione.

È questo in effetti l’aspetto che più colpisce chi oggi si addentrasse in quei fatti lontani nel tempo. Il maggio ‘68 sembra essere stato una rivendicazione d’essere che, in assenza di una rottura sociale fattiva, si è manifestata più come espressione che come azione. Tutti volevano comunicare e parlare. Ma il rifiuto del passato non riuscì mai a darsi un contenuto e dunque un presente. Slogan meravigliosi allora coniati, come «Sotto il pavè, la spiaggia», indicavano esplicitamente un’altra esistenza possibile. Ma questa, per realizzarsi, richiedeva una rivoluzione nei fatti oltre che nelle parole. Invece, sia i contestatori che lo Stato agirono come se ci fosse un patto implicito che proibiva a ciascuna delle due parti di spingersi troppo oltre. Se il movimento ebbe la forza di rifiutare il gioco politico di una falsa rivoluzione, ebbe anche la debolezza di non tentarne in tutti i modi una autentica. Era come se si fosse avvertito che stava accadendo qualcosa che avrebbe potuto condurre lontano, ma nessuno osava oltrepassare quella soglia. Molti teorizzarono il “punto di non ritorno”, tutti ne erano terrorizzati. Di fronte alla forza dei contestatori, lo Stato si era rivelato impotente. Ma il movimento, rimasto per due settimane padrone della situazione, cosa fece?
Purtroppo il movimento delle occupazioni del 1968 ripeté il medesimo errore della Comune del 1871. Anche allora, chi si era ritrovato inaspettatamente con Parigi in pugno «perse in poche ore tutti i vantaggi conquistati il mattino» — come ebbe a ricordare amaramente Lissagaray. Capitò lo stesso agli insorti del maggio ‘68, troppo soddisfatti della libertà acquisita e persuasi com’erano che la trasformazione radicale della società fosse realizzabile senza la distruzione dello Stato. Ed è davvero incredibile che proprio ciò che ha costituito uno dei maggiori limiti del movimento delle occupazioni, l’indifferenza nei confronti delle istituzioni, sia stato salutato dai situazionisti, occupati a congratularsi vicendevolmente per l’acume del proprio «senso storico», come uno dei suoi punti di forza. Viénet diede il tono compiacendosi del fatto che «per la prima volta in Francia, si è ignorato lo Stato: doveva essere questa la prima critica in atto del giacobinismo che per sì lungo tempo ha costituito l’incubo dei movimenti rivoluzionari francesi, compresa la Comune».
Fedele alla linea e senza nemmeno la parziale giustificazione di commentare quei fatti a caldo, nel descrivere la grande manifestazione del 24 maggio Mario Lippolis, dopo aver denunciato come «fantasmi leninisti» le ambizioni dei gruppuscoli che avrebbero voluto occupare i Ministeri lasciati incustoditi, gioisce nel ricordare come il Parlamento fosse stato «sovranamente ignorato».
C’è da restare sbalorditi. In quei giorni tutta Parigi era nelle mani del movimento. Lo Stato era assente. La classe dirigente si preparava a fuggire. La borghesia era «ammutolita dal terrore». Fra lo stesso esercito si notavano tentennamenti. Ma, anziché sfruttare quell’occasione per cercare di creare una situazione di non ritorno, il movimento si fermò dando al governo il tempo di riorganizzarsi e contrattaccare (le armerie non furono assaltate, i palazzi del potere non vennero dinamitati, le prigioni non furono abbattute, i tribunali non vennero incendiati…). In quel 24 maggio soltanto la Borsa fu data alle fiamme («solo superficialmente», ci tiene a precisare Viénet). L’idea preponderante sembra essere stata quella secondo cui il potere, se non lo si vuole conquistare, lo si deve ignorare. Di distruggerlo, non se ne parlò proprio.
Le immortali parole di Sade, con cui il Comitato Arrabbiati-Internazionale Situazionista aveva aperto il comunicato del 14 maggio che esortava alla vigilanza, non furono che una dotta citazione letteraria. «Annientate dunque definitivamente tutto ciò che potrebbe distruggere un giorno la vostra opera» — ben lo sapeva l’antico detenuto alla Bastiglia. Peccato che nessuno abbia raccolto il suo monito, nemmeno chi l’aveva riproposto.
L’IS ha mostrato bene come la riappropriazione dell’esistenza non debba riguardare l’ambito produttivo, ma toccare tutti gli aspetti della vita. Pur avvedendosi dei limiti della sinistra consiliarista, ricade però nel medesimo errore: riduce la libertà ad una mera questione di gestione. Se i consiliaristi pensavano a come autorganizzare la produzione, i situazionisti pensavano a come auto-organizzare la vita quotidiana. Ma un cambiamento sociale non sarà mai radicale finché si limiterà a dare nuove risposte a vecchie domande.

Deludendo le aspettative di tutti gli ideologi consiliaristi, situazionisti compresi, la stragrande maggioranza degli undici milioni di lavoratori francesi che nel maggio del 1968 entrarono in sciopero non occuparono affatto le loro fabbriche, ma le disertarono. Gli appelli lanciati verso la fine di maggio dai rivoluzionari, che invitavano a rimettere in moto l’industria a favore del movimento, rimasero giustamente inascoltati. Non erano mica i rivoluzionari a dover lavorare in fabbrica, loro occupavano antichi palazzi carichi d’atmosfera e trascorrevano il tempo deliberando. Ma, a differenza degli intellettuali che pretendono di educare alla rivoluzione e che pensano che il rifiuto del lavoro consista nel far sgobbare gli altri, i lavoratori francesi sapevano bene di non avere alcun interesse ad occupare volontariamente l’osceno angolo in cui il capitalismo li aveva parcheggiati. Se è vero che chi sta in basso non ha bisogno di chi sta in alto perché può benissimo autorganizzarsi da solo, è anche vero che nel mondo creato da chi sta in alto quelli che stanno in basso non hanno nulla di proprio da organizzare.
Un movimento sociale radicale non può fare a meno della sua parte distruttiva. Il sovvertimento dell’ordine sociale non presuppone solamente la soppressione della minoranza dominante, ma anche la distruzione del mondo da questa creato. Necessità della distruzione, quindi. Non come omaggio ad una tradizione romantica, non come riesumazione di un fantasma ottocentesco, non come soluzione ad ogni problema, bensì come condizione indispensabile per dare avvio concretamente all’autodeterminazione della propria esistenza. Purtroppo in quei giorni, da quanto è dato sapere, nessun rivoluzionario riuscì a distribuire agli insorti l’antica arma del sabotaggio e vincere la paura delle macerie.
(Da Machete n. 2, )

Riceviamo da compagni francesi e pubblichiamo a proposito degli ultimi avvenimenti oltralpe…..
Renzo Novatore
Renzo Novatore (Arcola, La Spezia, 12 Maggio 1890 – Teglia, Genova, 29 Novembre 1922) è uno pseudonimo, uno dei tanti, di Abele Ricieri Ferrari. È stato un anarchico individualista italiano, soprannominato “Il soldato del sogno”, un filosofo, poeta e un antifascista.
Attività insurrezionale
Nel 1910, accusato senza prove d’aver incendiato una chiesa, é condannato a tre mesi di carcere. Viene nuovamente arrestato l’anno seguente, questa volta per vandalismo . Durante la prima guerra mondiale diserta il suo reggimento il 26 aprile 1918. Giudicato in contumacia il 31 ottobre 1918, un tribunale militare lo condanna a morte per diserzione ed alto tradimento. Costretto alla fuga, ritornerà momentaneamente (a rischio della sua vita) presso la sua famiglia per dare l’ultimo saluto a suo figlio, morto negli ultimi mesi del 1918 . Capace anche d’esprimere una forte sensibilità, sosteneva di amare la moglie Emma di un «insuperabile amore».
Tornato in clandestinità, prende parte ugualmente al sollevamento popolare nel maggio 1919 a La Spezia, a cui partecipa anche l’amico Dante Carnesecchi; fa parte di un Comitato rivoluzionario che controlla la città ligure per alcune settimane. Il 30 giugno 1919, è fermato dopo essere stato denunciato. Condannato a dieci anni di carcere, è liberato alcuni mesi più tardi grazie ad un’amnistia generale. Mentre l’Italia è in preda ad una forte agitazione sociale, si unisce al movimento anarchico e prende parte a numerosi tentativi insurrezionali. Nel 1920, dopo aver assaltato un deposito d’ armi in una caserma della valle di Fornola, è nuovamente arrestato. Liberato poco dopo, partecipa ad un’altro tentativo insurrezionale a La Spezia. Il piano non riuscirà, ma prevedeva di conquistare le caserme della città e le navi della marina ancorate al porto. [1]
L’anarco-individualismo e attività propagandatrice
Il suo profondo desiderio di conoscenza unito ad una tenacia e ad una volontà già radicate lo spingono ad uno studio indefesso e personalissimo, a letture eretiche e sconcertanti: tra i suoi autori prediletti figurano Max Stirner, Friedrich Nietzsche, Georges Palante, Oscar Wilde, Henrik Ibsen, Arthur Schopenhauer, Charles Baudelaire.
Si definiva anarchico individualista, due parole che caratterizzarono tutta la sua romanzesca ed avventurosa esistenza, ed alle quali lui dava un valore e un significato ben preciso:
- «L’anarchico è solo colui che dopo una lunga, affannosa e disperata ricerca ha trovato sé stesso e si è posto, sdegnoso e superbo “sui margini della società”, negando a qualsiasi il diritto di giudicarlo. Ogni Società che voi costruirete avrà i suoi margini e sui margini di ogni Società si aggireranno i vagabondi eroici e scapigliati, dai pensieri vergini e selvaggi che solo sanno vivere preparando sempre nuove e formidabili esplosioni ribelli! Io sarò tra quelli!»
Notevole anche il contributo dato a numerose riviste e giornali anarchici a partire dal 1914, fra cui «Il Libertario» di La Spezia (fondato da Pasquale Binazzi), «Cronaca Libertaria» di Milano, «Iconoclasta!» di Pistoia (fondato da Virgilio Gozzoli e a cui collaboreranno diversi anarchici, tra cui Bruno Filippi, Giovanni Governato, ecc.), «Gli Scamiciati» di Pegli, «Pagine Libertarie» di Milano e «Il Proletario» di Pontremoli. Con Tintino Rasi, Giovanni Governato – il quale fornirà a Novatore i documenti falsi che poi gli saranno ritrovati addosso dopo la sua uccisione e che gli costeranno un processo, dal quale però verrà assolto grazie ad un’abile avvocato difensore – a e altri anarchici della sua tendenza e futuristi rivoluzionari fonderà con Tintino Rasi e Giovanni Governato la rivista «Vertice» (un solo numero pubblicato, La Spezia, 1921), dal chiaro sottotitolo «Rivista anarchica e di pensiero» ed il cui moto era «Forza Bellezza-Audacia Violenza».
L’avvento del fascismo
Dopo la marcia su Roma dei fascisti é tra i primi ad impugnare le armi e a combattere la violenza squadrista. Viene ucciso il 29 Novembre 1922 a Teglia, nel Genovese, dentro un’osteria, durante un conflitto a fuoco con i regi carabinieri, i quali gli avevano teso una vile ed infame imboscata.
Il pensiero: l’anarchia di Novatore
Per Novatore l’individualismo non ha come fine né il socialismo, né il comunismo, né l’umanità perché l’«individualismo ha per fine se stesso». Egli riteneva che un anarchico, prima di tutto, sperimenta in prima persona, nella normale quotidianità, il rifiuto di ogni autorità. L’anarchia iconoclasta è per Novatore «un modo speciale di sentire la vita», poiché colloca la propria individualità oltre ogni Stato, ogni sistema di governo, ogni convenzione sociale, ogni imposizione calata gerarchicamente dall’alto.
Nel corso della sua vita si é scagliato sia contro i borghesi e i fascisti, sia contro i socialisti (libertari o autoritari): in Il mio individualismo iconoclasta attaccò polemicamente l’anarchismo non-individualista:
- «Ogni Società che voi costruirete avrà i suoi margini e sui margini di ogni Società si aggireranno i vagabondi eroici e scapigliati, dai pensieri vergini e selvaggi che solo sanno vivere preparando sempre nuove e formidabili esplosioni ribelli! Io sarò fra quelli!»
Non di meno denunciò la mostruosità della Russia bolscevica che voleva sostituire un potere con un altro, un’autorità con un’altra. Novatore non era contrario all’abolizione della proprietà privata, poiché riteneva che l’unica proprietà inviolabile fosse solo quella spirituale ed etica. Il suo pensiero è esplicitato in Verso il nulla creatore:
- «Bisogna che tutto ciò che si chiama “proprietà materiale”, “proprietà privata”, “proprietà esteriore” diventi per gli individui ciò che è il sole, la luce, il cielo, il mare, le stelle. E ciò avverrà! Avverrà perchè noi – gli iconoclasti – la violenteremo! Solo la ricchezza etica espirituale è invulnerabile. È vera proprietà dell’individuo. Il resto no! Il resto è vulnerabile! E tutto ciò che è vulnerabile sarà vulnerato».
Citazioni
- «Nella vita io cerco la gioia dello spirito e la lussuriosa voluttà dell’istinto. E non m’importa sapere se queste abbiano le loro radici perverse entro la caverna del bene o entro i vorticosi abissi del male”. E continuava dicendo che “nessun avvenire e nessuna umanità, nessun comunismo e nessuna anarchia valgono il sacrificio della mia vita. Dal giorno che mi sono scoperto ho considerato me stesso come META suprema».
- «Il mio non è un pensiero o una teoria, ma uno stato d’animo, un modo particolare di sentire. Quando sentirò il bisogno di mettere decisamente in libertà i miei Centauri ed i miei furenti stalloni, sarà intorno a me un’orgia pazza d’amore e di sangue, perché io sono, lo sento, ciò che gli abitanti delle paludi morali della società chiamano delinquente comune».
- «Solo colui che sa apprezzare con impetuosa violenza i rugginosi cancelli che chiudono la casa della gran menzogna ove si sono dati convegno i lubrici ladri dell’Io (dio, stato, società, umanità), per riprendere dalle mani viscide e rapaci – inanellate del falso oro dell’amore della pietà e della civiltà, dei biechi predatori, il suo più grande tesoro, può sentirsi padrone e signore di sé, e chiamarsi anarchico».
Bibliografia
- Verso il nulla creatore, Edizioni Anarchismo, Trieste 2009.
sito dedicato a Novatore http://www.novatore.it/
devo dire che è davvero bello pieno di tenerezza e rabbia, per demolire razzismo cattive spero tu possa aiutarmi a rilanciare queste mie “piccole” inizative magari sul tuo bellissimo maremma libertaria, sto preparando, con altri 3 musicisti, anche uno spettacolo fantastico di popular songs meridionali e toscane con miei originali (cooperativa vapordotti, tarantella del potere) e tradizionali(brigante se more, maremma) con tambure tamburriate ecc..
Oggetto: link Video non chiamtemi clandestinohttp://www.youtube.com/watch?v=Iuujn8Lhbe4
Noi c’eravamo. Storie e personaggi del manicomio di Siena
Edizioni Cantagalli, Siena 2011 (pp. 224, numerose illustrazioni b/n)
Molto toccanti le esperienze dei viterbesi trascinati spesso a forza in una città “distante” in tutti i sensi.
Dal testo emergono una umanità profonda e il grande impegno civile di un folto manipolo di coraggiosi operatori che seppero anticipare la legge 180.
Un intero capitolo del libro è dedicato ai rapporti tra arte e follia con preziosi riferimenti all’artista viterbese Carlo Vincenti, la cui opera è ormai da anni oggetto di “riscoperta” per il suo intrinseco valore creativo.
( Antonello Ricci )
Nessuno può portarti un fiore
Con Nessuno può portarti un fiore,Pino Cacucci continua il suo personale lavoro sulla memoria. Come già fatto in precedenza con Ribelli!, raccolta di esistenze votate alla ricerca ossessiva dell’ideale utopico, anche qui vengono chiamate alla pagina vite che nella Storia sono entrate ma che da essa sono state espulse. Sette biografie di donne e uomini che hanno attraversato la propria epoca da banditi, martiri o eroi e che oggi rischiano di essere dimenticati per sempre.
Valga come esempio per tutti il racconto Sylvia, americana ingannata dall’amore e trasformata in arma inconsapevole per l’assassinio di Trockij, la cui vita Cacucci rivela attraverso il riuscito espediente di una lettera a una vecchia amica. Sorta di bilancio implacabile, ricco di rimorsi e colpe, in cui l’autore sembra farsi da parte, lasciando che sia la stessa protagonista a raccontarsi, come nel timore di mancarle di rispetto, di giudicare una vita già condannata dalla Storia.Una manciata di vite reali e vissute fino in fondo che, senza retorica e con molta sofferenza, finiscono per diventare esemplari. Scrive Cacucci:
“Ho pensato che i cuori dei ribelli, chissà, forse continuano a battere nei cuori degli altri ribelli che restano, e dei ribelli che verranno… perché nessuno muore mai del tutto finché c’è qualcuno che lo ricorda, finché resta viva la memoria di quei battiti affidati magari a un libro, a un film, ma soprattutto a quel sorriso dolce e in po’ venato di amarezza, il sorriso di chi non si rassegna e sogna ancora, malgrado tutto, malgrado il mondo che ci ritroviamo attorno.”
L’ Aspra Stagione
“Scrivemmo qualche giorno fa che quanto stava accadendo tra gli studenti non era un temporale di primavera ma una cupa tempesta. I fatti purtroppo ci danno ragione. Ma i fatti rimettono in discussione molte cose. E, in primo luogo, la strategia del compromesso storico. Non sottovalutiamo la serietà di quella strategia ma poniamo una domanda: come coinvolgere una gioventù disperata e condannata alla disoccupazione in un progetto di rinnovamento sociale che abbia come consoci le vecchie classi dirigenti, logorate e corrotte da trent’anni di esercizio del potere?».
Ken Saro Wiwa Sozaboy ED. Baldini Castoldi

Molti tempo fa, a metà anni ’70, un gruppo di studenti nigeriani, tra i primi in Italia, frequentò l’istituto tecnico minerario di Massa Marittima. Avrebbero dovuto essere i futuri tecnici ENI per sfruttare le risorse petrolifere del delta del Niger. Era da poco finita la guerra civile con il Biafra, ma ben presto, tra una dittatura militare e l’altra, le popolazioni Ogoni avrebbero iniziato una lotta senza fine per la loro stessa sopravvivenza, in un habitat sconvolto dalle trivellazioni petrolifere , inquinamento e tassi di mortalità abnormi, senza che i benefici dei petrodollari uscissero dalle tasche dei militari e i loro scagnozzi. Il leader più prestigioso e famoso di questo movimento fu senz’altro l’intellettuale, l’uomo di teatro, il regista televisivo, lo scrittore Ken Saro-Wiwa. Arrestato dal regime militare, dopo un processo farsa fu impiccato con altri militanti il 10 novembre del 1995. In Italia possiamo leggere il suo capolavoro, il romanzo Sozaboy, scritto in Rotten English un miscuglio quasi intraducibile di inglese corrotto nigeriano, espressioni idiomatiche , dialettali e orali, ottimo inglese, che hanno costretto Roberto Piangatelli ad un capolavoro traduttivo immane. Un linguaggio disordinato che crea disordine, ai suoi parlanti offre il vantaggio di non avere nè regole nè sintassi. Si sviluppa nell’arbitrio ed è parte della società dislocata, disorganizzata e discordante in cui Sozaboy deve vivere, agire e non realizzare la sua esistenza. ( S.P.)
“Numbero uno
Comunque, all’inizio, tutti erano contenti a Dukana.
Tutti i nove villaggi danzavano e mangiavano un sacco di mais con le pere snocciolando racconti sotto la luna. Perchè il lavoro dei campi era finito e l’igname stava crescendo proprio bene. E perchè il vecchio governo cattivo era morto ed era arrivato un nuovo governo, un governo di sozasoldati e di polizia. Tutti dicevano che sarebbe andato tutto bene a Dukana poichè c’era un nuovo governo. Dicevano che kotuma culdicenere non poteva più chiedere altre mazzette alla gente di Dukana. Dicevano che tutti quei poliziotti di Bori che erano abituati a papparsi un sacco di mazzette dalla gente incasinata nei processi,avrebbero finito di pappare. Erano tutti felici perchè da quel momento anche il magistrato del tribunale di Bori avrebbe iniziato a dare giuste sentenze. E la polizia stradale avrebbe fatto il proprio lavoro proprio per bene. Una donna disse addirittura che il sole avrebbe brillato stupendamente e che la gente non sarebbe più morta, poichè all’ospedale ci sarebbero state medicine e il dottore non ti avrebbe più chiesto dei soldi prima di operarti. Sì, erano tutti felici a Dukana; e tutti cantavano. Anche io. Perchè, essendo io un giovanotto e un apprendista autista, non ci avrebbero più creato ancora tanti problemi per strada….
Comunque , a dire la verità, per un certo periodo le mazzette scomparvero. Ma dopo un po’ tutto ricominciò. La polizia stradale iniziò chiedendo pochi spiccioli. Poi iniziarono a chiederne di più. Fino a che chiesero mazzette ancora più grandi di prima. Allora la gente comincia a dire che ora che sono al comando i soldati e la polizia, nessuno sarebbe stato capace di fermare la polizia stradale quando si pappava le mazzette. Perchè un governo non può mica arrestare se stesso…noi non comprendevamo mica cosa stava succedendo. Ma la radio e altre persone raccontavano di come la gente morisse. E un sacco di gente stava tornando al proprio villaggio, da luoghi molto lontani. Noi dei trasporti ci mettemmo a fare un pacco di soldi. Un sacco di casino, un pacco di soldi. Al parcheggio dei furgoni la gente che tornava raccontava un mucchio di cose. Ho sentito un sacco di storie a quel tempo. Su come ammazzavano la gente sul treno, tagliandoli la testa o una gamba o spaccandogli la testa con il machete o colpendoli con arco e frecce. Pian piano comincia a prendermi paura. Ben presto tutti iniziano ad avere paura. Perchè adesso c’è tutto questo casino? Eh ? Perchè? Anche a Dukana la paura comincia a impadronirsi di tutti. La radio continua a blaterare discorsi sempre più complicati, parole sempre più incasinate….Il Pastore Barika della Chiesa della Luce di Dio, la chiesa più importante di Dukana, andava in giro a dire che il mondo sarebbe finito presto. A me questa storia non mi piace. Come poteva finire il mondo, e io, che non avevo ancora preso la patente? Vi pare una bella cosa? Come poteva finire il mondo, e io,che non mi ero ancora sposato? Questo Barika è proprio un ebete. Non mi è piaciuto proprio quando diceva tutte quelle cretinate. E’ un uomo inutile dentro una chiesa inutile….così quella sera ero all’African Upwine Bar. All’inizio non c’era tanta gente. Ordino una bottiglia di vino di palma alla cameriera. Questa cameriera è una ragazza giovane, col culo che balla quando cammina. La ragazza ha più tette che anima, stanno dritte come colline. Mentre la osservo il mio uomo comincia a rizzarsi pian piano. L’ho pregato di non farmi fare brutta figura, specialmente perchè quella sera non mi ero messo le mutande…”
———————————————————————————————————————————————–
E’ uscito il libro di David Gilbert ” Love and Struggle” per ora solo negli USA, David è detenuto dal 1981 , ex leader studentesco capofila dlle lotte contro la guerra in Vietnam e militante degli Weather Underground negli anni ’70, organizzazione armata della sinistra radicale americana. A questo proposito vedere il bellissimo film http://www.pbs.org/independentlens/weatherunderground/
e ancora http://it.wikipedia.org/wiki/Weather_Underground

Cinema
Del film nutellaro e pavido di Giordana, ” Romanzo di una strage” abbiamo già detto all’inizio.
Qui invece vogliamo segnalare il film ” Diaz” , di Daniele Vicari, un film coraggioso
il trailer http://youtu.be/RNynI9mp-_M

qui un blog interessante sul film
http://www.militant-blog.org/?p=6765
e qui una bellissima recensione di Daniele Vicari
A proposito di “Diaz” di Daniele Vicari
Quattro ragazzi francesi riemergono alla luce del giorno. Hanno passato la notte chiusi in un bar, per sfuggire alla vendetta degli uomini in divisa. Si avventurano per le strade deserte. Giungono alla Diaz, ne oltrepassano i cancelli. Non sanno niente. Non immaginano. Ma non ci mettono molto a capire. La palestra che gli si spalanca dinanzi è la mappa perfetta della carneficina. Il sangue è ovunque. Sui termosifoni, sugli zaini, negli angoli. I due ragazzi più giovani piangono. I due più grandi, più esperti, di cui è chiaro il ruolo negli scontri, rimangono sgomenti. Poi lei, l’unica donna del gruppo, con un pennarello scrive: Don’t clean up this blood. Non cancellate questo sangue. E ti viene un groppo in gola che è tutto. Ma non fai a tempo a rielaborare. Neppure a far fluire il disgusto e l’appartenenza, che lui, il nero del Blocco Nero, fugge. Lontano da quello scenario d’orrore. “Stavano cercando noi”, dice. E depone le armi. Un senso di colpa improvviso quanto inarrestabile. “Abbiamo sbagliato tutto”, in sostanza. E si arrende. In meno di un minuto, la scena più grandiosa e la quella più infima di Diaz, il film di Daniele Vicari. Come dire: splendore e miseria di una pellicola. Ma davvero siamo ancora a questo?, ti chiedi. A domandarci se davvero quei cani siano entrati nella scuola alla ricerca di qualcuno in particolare, di qualcosa nello specifico?
Allora, giunti a questo punto – undici anni dopo quei giorni di rabbia e di furore – diventa irrimandabile affermare che le storie, le micro-storie – quell’intreccio di sogni intimi, motivazioni private, emozioni e casualità personali – non ci interessano più. Perché sui libri di storia c’è scritto che la battaglia di Gerusalemme è stata combattuta il 14 luglio del 1099 tra l’esercito crociato e le milizie egiziane. E a nessuno preme sapere degli ardori, dei bisogni, dei frammenti di vita dei singoli crociati genovesi o delle sfortune, delle pieghe del destino, che hanno portato il tal soldato a sferrare o a subire i tali colpi. L’assedio e la battaglia di Gerusalemme sono storia. Punto. E l’analisi che ne consegue è politica. Se vogliamo sopravvivere al continuo, paraculistico richiamo all’emotività che nulla spiega e di tutto fa libero arbitrio ed interpretazione, dobbiamo considerare Genova alla stregua di Gerusalemme. Di Bouvines o di Calatafimi. Storicizzata freddamente, lucidamente, impietosamente, sino a renderla impersonale. Immateriale. Inequivoca. Come lo sono tutte le battaglie che restano. Un nome, un richiamo. Immediato, lampante. No, quel sangue non l’abbiamo cancellato. Tutt’altro. Quel sangue è nostro. E tale resterà. Ma scegliere di frammentare l’ingranaggio collettivo della memoria e della rivendicazione in una miriade di facce, provare cinematograficamente a seguirne bandolo e matassa, finisce per fare un torto alla politica. All’analisi di quei giorni. Undici anni dopo. Non un giorno o due.
In Bloody Sunday di Paul Greengrass i paracadutisti inglesi sono una massa informe, senza soggettività, speculare e contraria alla massa fungibile dei manifestanti irlandesi. E quando il primo colpo piomba sulla folla, il segnale d’attacco non è imputabile ad un soldato, alle sue sensazioni del momento, alle sue paure. Uno preme il grilletto, ma è l’Inghilterra intera a sparare. E tra quella singola faccia, che nessuno neppure ricorda, e il Principe di Galles ci passa lo scarto di zero. Meno di zero. Sono un tutt’uno. Perché è inutile, è dannoso, è paraculistico, seguitare con la tiritera menzognera del gioco soggettivo. Dell’effetto Sliding doors per cui ognuno di noi, in base ai casi della vita, poteva trovarsi da una parte o dall’altra. Indifferentemente. Nient’affatto. Non ci è bastato dover discutere nei bar, sui posti di lavoro, negli spogliatoi del calcetto, di Carlo e di Placanica, del “Tu che avresti fatto al posto del carabiniere”? Intendiamo ancora proseguire sulla scia di quella retorica? Tanto da non comprendere se la scuola cinematografica anglosassone sia capace di tali operazioni a cuore aperto perché gli inglesi stanno provando a saldare i conti col passato o viceversa. Fatto sta che noialtri, a giudicare dal prodotto finito, siamo ancora lontani da quei livelli.
Anni luce lontani. Per indole melodrammatica. Per pavidità. Per opportunismo. Per spirito cortigiano. E date le premesse, sembra appena appena assurdo dover rispolverare gli argomenti di allora per un dopo-cinema di oggi. Come se fossimo nella calda estate del 2001. Ma tant’è. Il lenzuolo ha parlato. Violenza, un mare di violenza. Sangue, tanto sangue. E la monta strisciante della tensione sui muscoli cervicali che si fa indignazione, poi rabbia autentica. Ma, permettetemi di dire, quel sangue è elemento neutro. Forse il più paraculo fra tutti gli elementi. Perché dinanzi ad un celerino di cento chili che carica a fondo il suo tonfa e lo schianta sulla faccia minuta di una ragazzina indifesa ed immobile, fino a farne schizzare il sangue e i frammenti di ossa nelle casse del dolby surround, c’è da essere davvero degli amanti dello Snuff per non provare ribrezzo. Dinanzi alle umiliazioni, dinanzi all’infamia, dinanzi a denti, tagli, cicatrici, non si può parteggiare per quell’immonda immondizia in divisa da assassino. A meno di non essere degli psicopatici della medesima risma. Ma la lunga gestazione del nostro lutto collettivo meritava qualcosa di più di una (finalmente) ben documentata sequela di orrori. Delle prove di un massacro che fa fremere di sgomento un arco istituzionale talmente vasto da rimanerne stupiti. Da rimanerne neutri.
Meritava, tanto per dirne una, dei nomi e dei cognomi. Dei responsabili presentati col sottopancia. Magari anche di un counter a cadenzare i momenti. Ne avrebbe risentito la licenza poetica dello sceneggiatore, certo. Saremmo finiti tra le braccia di un filmone didascalico e la cosa avrebbe fatto arricciare il naso ai cinefili. Ma avrebbe tolto al pubblico la perversa parvenza di trovarsi dinanzi ad una supposizione artistica. Perché Genova non è una di quelle storie che concludi con Tutti i riferimenti a fatti e persone sono puramente casuali. A Genova nulla è stato casuale. E il pubblico non deve ipotizzare, da quel che ha letto o visto altrove, che quel pezzo di merda è De Gennaro e quell’altro stronzo è Manganelli o Canterini. No. Il pubblico deve saperlo per certo. Non ci possiamo lamentare delle assoluzioni in tribunale se neppure nella finzione siamo in grado di condannare. Condannare, si. Come i peggiori forcaioli sulla piazza. Occhio per occhio, dente per dente. Altro che storie. Altro che affondi di sciabola sul moribondo Berlusconi. Una volta per tutte: l’operazione di polizia di Genova è stata architettata, pensata, studiata, affinata, negli incontri strategici tra i più alti papaveri dello Stato democratico. Ed è andata esattamente come doveva andare. Terrorismo dall’alto. Stroncare un movimento liberando le proprie truppe d’occupazione interne. Dissuaderlo, con la pena di morte, dal tentare di nuovo di colorare le strade di protesta. Genova non è stata la manovra emotivamente instabile di quattro disadattati in una stanza dei bottoni. Non il frutto della scelta avventata di un singolo scosso da un abbandono sentimentale o da una tirata di coca. O, ancora, la semplice sommatoria di migliaia di vite. Genova è come la Gerusalemme crociata: un campo di battaglia dove ognuno ha fatto la sua parte e una parte ha vinto. Mentre l’altra per dieci anni almeno ha sentito addosso gli spasimi della tortura. Anche se non era fisicamente alla Diaz. O a Bolzaneto.
Ma dal film tutto ciò non si evince. E attorno al grumo di sangue secco, o alla ferita ancora aperta e pulsante, il contesto riproposto oggi è il cliché di allora. Come se la nostra reale condanna fosse vivere in una galleria del vento perpetua ed essere costretti – incubo tra gli incubi – a dover ripetere Genova per altri venti, cinquanta, cento anni. Senza spostare una sola pedina, senza modificare una sola opinione. Le lunghe gonne variopinte delle danzatrici gitane attorno ad un rogo sul mare, a richiamare l’amore, il sesso e la libertà, a sospirare su quel che poteva essere e non è stato; i dread, le canotte, i torsi nudi, gli spinelli e i sacchi a pelo a testimoniare la bellezza della diversità, della varietà, dell’unità tra opposti, della curiosità e della meraviglia della conoscenza; l’idioma francese e tedesco dei casseurs, degli “anarchici”, di quelli che gli scontri li fanno per davvero, a sottolineare che il Blocco Nero esiste, ma non è cosa di qua, non è cosa nostra, che sono dei professionisti del casino e chissà chi ce li ha mandati; il vecchio sindacalista, il buon giornalista idealista, il mediattivista, a fungere da figure idealtipiche, fughe in avanti nell’affanno della narrazione. E il cliché più cliché di tutti: il poliziotto buono. Quello che il cuore non l’ha sepolto sotto la divisa. Quello che, dopo aver addestrato una muta di cani, d’incanto, dinanzi al nemico, sente che la coscienza gli rimorde. E di messicano qui, più che la macelleria, c’è tutta la trama di una brutta telenovela. Il poliziotto buono – che qui poi sarebbe Fournier, capace di chiedere “scusa” per la tentata strage con la stessa disinvoltura con cui si chiede alla signora dirimpetto se ha un pizzico di sale; quando non lo stesso Canterini, che vorrebbe evitare che i suoi cocainomani si lancino sulla preda dopo averne sentito l’odore –, il poliziotto buono, si diceva, è la chiave di volta della nostra cinematografia. Di più. Con la sua capacità di intercettare le speranzose e mai dome illusioni delle anime belle, anche dinanzi allo scempio più pianificato; con il suo sapersi presentare come una specie di figlio del Nilo predestinato, affidato alle acque durante un’epidemia e fondatore di chissà quali nuove città d’ordine e armonia; il suo saper allontanare la lacerazione dell’autocritica dallo spettatore desideroso di dicotomie rassicuranti; con i suoi bisogni materiali, i figli a casa, i bacetti alla fidanzata nel bel mezzo di uno scempio. Egli stesso, è, la chiave di volta della nostra dubbia moralità. Noi non siamo inglesi. Non riusciremmo ad ingoiare la fedeltà al corpo dell’ultimo parà, che dinanzi al tribunale militare nega d’aver notato irregolarità a Derry e insabbia i morti senza lasciare scampo ai benpensanti. Noi abbiamo bisogno di Perlasc(hi), di Salv(i) D’Acquisto, di eroi positivi che dimostrino la nostra natura di “brava gente” anche nel buio denso delle epoche più tenebrose. E ci sottraggano alle responsabilità della critica d’opposizione. Dell’uomo che, da solo, salva la specie. Del germe che assicuri lunga vita ai buoni sentimenti. Che ci permetta di tornare a casa e dire che, alla fine, era solo un film.
Ma Genova no. Non è stato un film.

Corti militanti LTMD
La scrivania di Luciana Bellini
Forse qualcuno si chiederà quale è stato il libro più venduto a Massa questo autunno. Se pensate a Ken Follett a Baricco o De Carlo siete fuori strada. No, è molto più vicina a noi l’autrice ( e in tutti i sensi ) è Luciana Bellini, scrittrice contadina di Manciano, già nota in Toscana e fuori per i suoi libri-ricordi (scritti in un italomaremmano irresistibile) di una epopea ,quella delle campagne maremmane nel secondo dopoguerra. Luciana ultimamente è apparsa in tv,è stata subissata di interviste e articoli,è stata una vedette al festival internazionale della letteratura resistente,ma non si è montata la testa,anzi,è raro esempio di grande modestia simpatia e carica umana; non è possibile rimanere indifferenti alle sue presentazioni,ne sanno qualcosa i numerosi amici del fondoBoccardi che l’hanno seguita lo scorso anno per la presentazione de “la capitana” e la seguiranno per la presentazione in Pianizzoli nella casa del compianto poeta Lio Banchi del suo ultimo libro,il capolavoro “la terra delle donne” edito da stampa alternativa e andato a ruba in decine di copie solo con il passaparola di quanti l’avevano letto. Come dice efficacemente Antonello Ricci nella postfazione “..testimone partecipe e acuto del brusco tramonto della civiltà contadina, anche stavolta Luciana ha un’invenzione sorprendente. Si fa voce , generosa e inconfondibile,degli ultimi senza-voce: le donne maremmane nella riforma agraria degli anni cinquanta:è una di loro; le ascolta con amore ne vince reticenze e pudori arcaici, le spinge a raccontarsi , a raccontare cose che mai avevano trovato il coraggio di dire, a nessuno. La piccola e orgogliosa contadina maremmana,con i suoi occhi vivissimi e la sua voce unica, sta sulla scena di questi racconti con la consumata maestria di un antico cantastorie”.
…..” tra poco avrò 95 anni , eppure non mi sento nè vecchia nè stanca. A volte mi domando se saranno state quelle preghiere che lei m’aveva promesso o sarà stata quella forza che io da sempre ho sentito dentro. Non lo so se l’allegria,la pazienza, la speranza e la fiducia aiutano l’amore a vive’ o se è l’amore che aiuta la vita…Ho conosciuto ‘l disagio e la sofferenza, è vero che lottato,ho sudato, ho pianto, ma sempre, anche nei momenti più bui ho sperato,e anche con l’aiuto della divina provvidenza,eccomi qui. E quella terra che prima era ‘n sogno e basta l’ho qui davanti. Lo sentii subito che lo volevo quel podere, da quando l’ente maremma cominciò, e dal niente si videro le case che fiorivano come le margherite a primavera. Una casa tutta mia ! Un posto sicuro dove niente e nessuno ciavrebbe potuto più mandà via. E tutti que’ muri bianchi, tutti que’ tetti rossi che baldanzosi rianimavano quella terra ferma, erano la sicurezza. E’ cosi che quel marrone s’è allargato, ‘l verde ha sconfinato e ‘l giallo è diventato pane. Ora qui intorno è tutta una vigna, tutto un uliveto e l’occhio si perde…’l forteto li davanti, più scostati i monti e là, là c’è ‘l mare ‘n lontananza.
Questo pezzetto di maremma è casa mia da sempre oramai, e anche se l’anagrafe dice che so’ più che vecchia, mi vergogno quasi a dillo, ma mi sento sempre addosso la forza della vita.” ( da La terra delle donne pag. 17)

12 maggio Pisa, manifestazione dei gruppi anarchici toscani nel 40 simo anniversario dell’assassinio di Franco Serantini

Link utili www.stefanopacini.org
www.radiomaremmarossa.it
www.carmillaonline.com www.ltmd.it www.infoaut.org
http://collettivoanarchico.noblogs.org www.senzasoste.it
www.finimondo.org
Maremma Libertaria Esce quando può e se e come gli pare. Non costa niente, non consuma carta e non inquina, se non le vostre menti. Vive nei nostri pensieri,perchè le idee e le rivoluzioni non si fanno arrestare, si diffonde nell’aere se lo inoltrate a raggera. Cerca di cestinare le cartoline stucchevoli di una terra di butteri e spiagge da bandiere blu,che la Terra è nostra e la dobbiamo difendere! Cerca di rompere la cappa d’ipocrisia e dare voce a chi non l’ha, rinfrescando anche la memoria storica, che senza non si va da nessuna parte. Più o meno questo è il Numero 7 del 25 aprile 2012.Maremma Libertaria può essere accresciuta in corso d’opera ed inoltro da tutti noi, a piacimento, fermo restando l’antagonismo , l’antifascismo e la non censura dei suoi contenuti.
In Redazione, tra i cinghiali nei boschi dell’alta maremma, Erasmo da Mucini, Ulisse dalle Rocche, il Fantasma della miniera, le Stelle Rosse stanno a guardare, Complici vari , Ribelli di passaggio,maremmani emigrati a Barcelona.
No copyright, No dinero, ma nel caso idee, scritti, foto, solidarietà e un bicchiere di rosso.
Nostra patria il mondo intero, nostra legge la Libertà, ed un pensiero Ribelle in cuor ci sta (Pietro Gori) http://youtu.be/_KVRd4iny8E
Potranno tagliare tutti i fiori, ma non riusciranno a fermare la Primavera (Pablo Neruda) http://youtu.be/wEy-PDPHhEI (Victor Jara canta Neruda)

Sempre, comunque e dovunque : Libertà per tutti i compagni arrestati !– Fori i compagni dalle galere !-Libertad para todos los presos ! – liberdade para companheiros presos! -comrades preso askatasuna!- liberté pour les camarades emprisonnés!-freedom for imprisoned comrades !- Freiheit für inhaftierte Genossen!- ελευθερία για φυλακισμένους συντρόφους ! – الحرية لرفاق السج
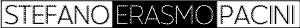

















0