Alessandro Pagni. Da quanto tempo non sogniamo il mondo ? Stefano Pacini:epopea contadina di amore e anarchia
Da quanto tempo non sogniamo il mondo?
Stefano Pacini: epopea contadina di amore e anarchia.
Le due passate
Abbiamo preso l’assegno
siamo risaliti sul furgone
Lei ci ha salutati con la mano
Indossava un paio di jeans attillati
e una maglia bianca
La sua nuova pelle splendente
era un richiamo alla vita
(Massimo Volume, Qualcosa sulla vita)
Stefano Pacini, anarchico maremmano, dal cuore puro e lo sguardo lucido, che non nasconde con filtri polarizzatori o paraluce, quel luccicare di emozioni in punta dita, è il fotografo di un tempo “differente” (definirlo “di altri tempi” sarebbe un luogo comune orribilmente riduttivo, che non rende giustizia al suo lavoro), un tempo che non si perde nell’analisi logica delle sensazioni, nel becero pollaio dei social network, nelle arroganti menzogne del politichese.
Il suo è un tempo svelto e fresco, ma indelebile come un marchio, è il tempo della militanza, che non c’entra propriamente ed esclusivamente con le convinzioni politiche, che non ha niente a che vedere con le istituzioni e la passione per l’immobilismo, tanto cara a questo paese. È una “militanza dell’esserci”, la scelta di muoversi e seguire i flussi delle pulsazioni collettive, i luoghi e i momenti in cui la vita c’è, dove vibra, dove le idee si scornano, si intrecciano, ma bruciano di una rabbia gioiosa. Che forse poi è il segreto che si nasconde dietro a certi giorni passati, il segreto di tanto attaccamento a certi ricordi.
Questo libro, che racchiude gli scatti più significativi della sua produzione, dal 1974 al 2014, è un taccuino di appunti, un diario appassionato di come era il mondo “prima”. E quel “prima”, non deve necessariamente leggersi con una qualche connotazione nostalgica o un retorico e inutile “prima si stava meglio”; il “prima” a cui alludo è il senso del momento, dell’attimo irripetibile, è l’arco di tempo in cui non cerco di interpretare gli eventi ma lascio che mi entrino dentro e mi modellino, perché ne faccio parte: cimeli da conservare e guardare più tardi, nella solitudine dei nostri pensieri. Oggi, inevitabilmente, quel taccuino che ha visto il mondo, fatto di un ventaglio invidiabile di occasioni possibili, assume l’aspetto di un’antologia di lezioni imparate, punti su una mappa che tracciano il vertiginoso, struggente, racconto di una vita.
Un temporale, acqua che picchia sui parabrezza delle automobili posteggiate. E noi tutti insieme, come un grottesco millepiedi, riparati sotto lo stesso telo, ci muovevamo all’unisono, ridendo di quella piccola tenera cosa. Una giornata di sole che odora di crema protettiva e birra ormai tiepida. E il mare che sembrava lì solo per te, per raggiungerti, forzare la resistenza della sabbia e scivolare furtivo sulla tua pelle. Un frullare caotico di ali a Milano, davanti all’armatura di un Duomo in ristrutturazione. Le nostre frasi a metà e le parole non dette, nel silenzio di quel bosco di lapidi, nel cimitero ebraico di Praga.
Ma quanto eravamo belli?
Lo siamo sempre se riconsideriamo certi momenti passati, dalla giusta angolazione, giorni che sono il senso ultimo di un vivere laico, che non contempla, anzi non si preoccupa di un “dopo”.
La forza della fotografia di Stefano Pacini è questo farti parlare in prima persona, renderti tanto partecipe della sua emozione da sentire che in qualche modo eri lì con lui, di fianco, a respirare la stessa aria, sotto lo stesso sole.
Stefano è un Tano D’Amico della bassa Toscana quando interiorizza i movimenti giovanili di lotta e non accettazione, è un Dennis Stock della Maremma quando guarda alla strada e al partire con l’urgenza di un beat che si nutre di avventure. Ma più di tutto è un fotografo del presente, dello scorrere, del fluire. E la sua fotografia ha poco a che vedere con concetti astratti e progettazione, sperimentazione e avanguardia. Il suo occhio, il suo stile, il suo modo, sono quelli del gitano: è come ascoltare il primo disco dei Violent Femmes, un inno alla vita dolente e pieno di luce, che strappa come tagli la penombra, un fluire inarrestabile che ad un certo punto si accascia struggente ed esausto, per concedersi un po’ di dolcezza. Penso a quella fotografia in riva al mare a Follonica, datata 1977 e la penso con in sottofondo Good Feeling, la traccia più intima di quel disco: un uomo e una donna che danzano di fronte al mare, nell’ultima luce del giorno che lento muore. A lui si alza il lembo della giacca dietro la schiena per il vorticare dei loro passi, lei si sostiene su una gamba tenendo il tempo con l’altra. E non c’è altro che conta di più in quel momento, non c’è niente oltre la sabbia, l’acqua, il cielo, loro due e la voce di Gordon Gano che dice sommessa: Good Feeling, Won’t You Stay With Me, Just A Little Longer/It Always Seems Like Your Leaving ,When I Need You Here Just A Little Longer.
Queste, come fu intitolato il volume retrospettivo di Robert Frank, sono le linee della mia mano, sono le linee della mano di Stefano, i suoi percorsi, i suoi luoghi, la summa di cose che può chiamare “casa” pur non avendo una collocazione fisica o temporale, anzi, soprattutto non avendo una collocazione fisica e temporale, perché sono l’unico vero bagaglio che ci portiamo dietro fino alla fine.
Stefano con le sue fotografie mi ha insegnato che l’attimo decisivo non è una pallottola congelata a mezz’aria, l’attimo decisivo è il momento di vivere, ed è solo qui e adesso, non ieri, non domani e non altrove.
Alessandro Pagni , Siena, dicembre 2015
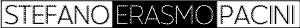

0